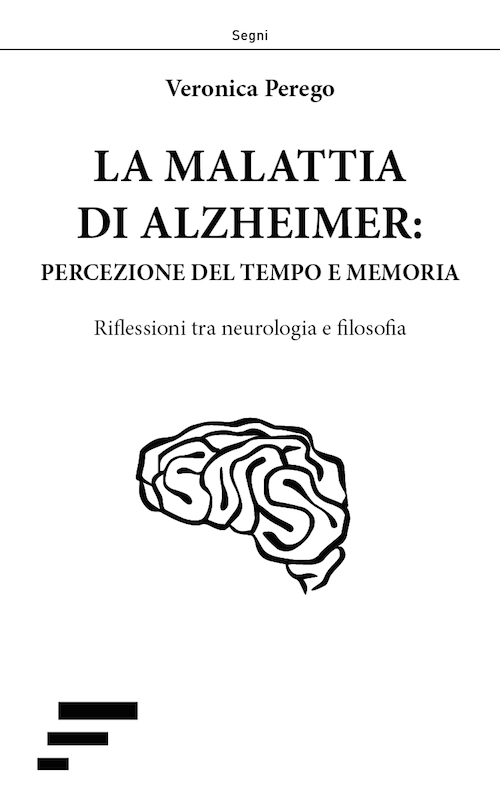In foto, Veronica Perego
La malattia di Alzheimer

SALVARE DALL’OBLIO E DALLA MEMORIA
di Franco Di Giorgi
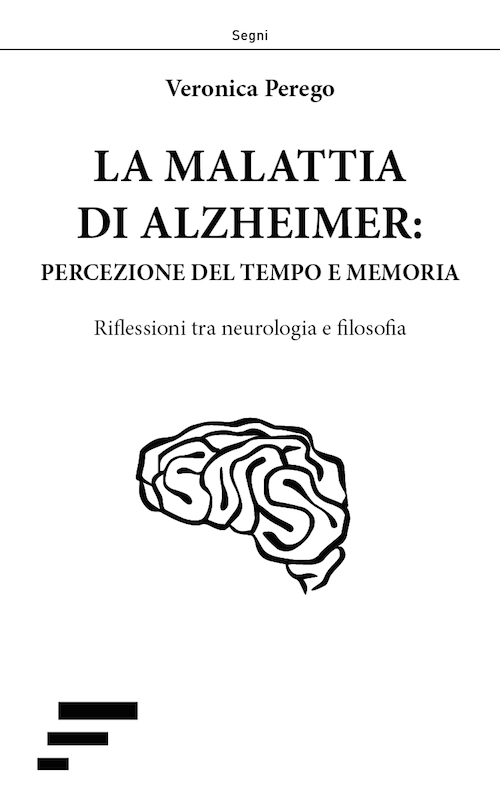
1 . Una delle categorie kantiane fondamentali della ragione pura è la relazione. E ciò non solo dal punto di vista logico-trascendentale, ma anche da quello ontologico e neurologico. Quando, infatti, nel suo primo saggio, ossia nella sua tesi di laurea (La malattia di Alzheimer: percezione del tempo e memoria. Riflessioni tra neurologia e filosofia, Caosfera 2019), Veronica Perego ribadisce che compito della moderna neurontologia è «rintracciare nell’ontologia cerebrale l’origine delle strutture del pensiero consapevole» (p. 5), con ciò implicitamente intende riprendere la lezione di Aristotele, secondo cui la filosofia è la scienza che ricerca le cause dell’essere. Che cosa vuol dire infatti «rintracciare nell’ontologia cerebrale l’origine delle strutture del pensiero consapevole», se non, appunto, ricercare le cause materiali dell’essere? E l’ontos cerebrale, il cervello, vale a dire, appunto, la materia grigia, è certamente la sostanza in cui è possibile reperire le strutture della mens, della mente, come pure della mnemé, della memoria, e quindi del pensiero consapevole. Una di queste strutture della mens risiede proprio nella categoria kantiana di relazione, la quale, non a caso, corrisponde a una delle dieci categorie aristoteliche alle quali il pensatore di Könisberg ha applicato il suo ordine prussiano. Sicché, pure dal punto di vista neurontologico la relazione si può considerare non solo una condizione trascendentale della possibilità del conoscere, ma anche una condizione fisiologica, se non addirittura istologica di quella medesima possibilità.
Il rapporto fondamentale di causa-effetto, su cui si fonda l’intera impalcatura della logica, della scienza e quindi dell’epistemologia, rientra ovviamente nella categoria di relazione, giacché esiste un legame dialetticamente intrinseco tra i due elementi. Non si può considerare logicamente l’uno senza presuppore neuro-logicamente anche l’altro. E poiché quel legame, quella relazione si produce a livello inconscio, cioè a priori, si può parlare in riferimento a questa categoria di una trascendentalità fisica o fisio-logica. Compito della filosofia sarà di coglierla a livello logico-trascendentale, mentre compito della scienza neurologica sarà di rilevarla a livello fisico-trascendentale o fisio-logica.
Dato, ad esempio, un effetto B, ogni forma di scienza, e quindi la filosofia (che per lo Stagirita è la regina di tutte le scienze), è necessitata a ricercarne il motivo, il motus originario, la causa A. Bisogna dunque risalire da B ad A. Questo movimento del risalimento è anche quello che i neurologi colgono tra le cellule neuronali in presenta di un segnale, di uno stimolo. C’è d’altronde un percorso che questo segnale deve compiere da un punto B (le cellule nervose stimolate in una particolare zona del cervello) a un punto A (il tendine del ginocchio stimolate da un martellino). In quanto elementi a priori, né il percorso compiuto dal segnale né tanto meno la struttura dell’intero sistema nervoso dipendono ovviamente dalla volontà dell’uomo, il quale altro non è, come diceva già Marco Aurelio, che l’insieme, la risultante delle molteplici sinergie relative ai vari sistemi e ai diversi organi che lo costituiscono. La sinergia è quella che si instaura enigmaticamente tra le finalità e le funzionalità sia degli organi sia dei sistemi stessi cui essi mettono capo. Quello che si avverte a livello cerebrale, neuronale o della mens non è altro che la conseguenza, l’effetto di una causa che si verifica a livello fisico o sensoriale. L’intero movimento ha quindi una realtà psico-fisica. E così pure l’essere umano nella sua essenza è inscindibilmente una realtà duale, una realtà psico-fisica.
Ciò significa che questo movimento, questa cor-relazione tra la causa tattile e l’effetto neuronico, avviene in un certo tempo (oggi misurabile grazie a Luigi Galvani, il quale, tra l’altro, comincia i suoi esperimenti con le rane proprio nell’anno in cui esce la prima edizione della Critica della ragion pura, cioè il 1781), determinando così una temporalità, un prima e un dopo. Ma nella Fisica Aristotele aveva già intuito che il tempo, il chrónos, è la misura del movimento secondo il prima e il dopo: una misura, un metrón, che ha la sua condizione nell’anima e quindi nell’intelletto, il quale funziona grazie alle dieci categorie, tra cui, appunto, la relazione, forse la più importante dopo quella di sostanza.
La realtà psico-fisica dell’uomo si evince pertanto anche dal fatto che non si dà misurato – non solo il movimento oggettivo ed esterno, secondo il prima e il poi spaziale, ma anche il movimento interno secondo il prima e il poi temporale – senza misurante – non solo soggettivo ed interno (l’anima), ma anche oggettivo ed esterno (il corpo) – , e reciprocamente non si dà misurante (anima-corpo) senza misurato (movimento esterno e interno, spazio-temporale). Non si dà misura e quindi tempo, senza movimento, cioè distanza spaziale tra causa ed effetto. La memorizzazione psicofisiologica, vale a dire l’apriorizzazione del tutto inconscia e quindi trascendentale di questa durata, crea al contempo un’attesa strutturale.
Sicché, a fronte del dato sensorio in A, mi attendo che, sebbene in un tempo minimo e impercettibile, si verifichi l’avvertimento neuronico, la presa di coscienza in B. Diciamo “si verifichi” non a caso, perché è proprio in virtù di questa attesa minimale e irrilevante che noi avanziamo una qualche pretesa di verità in questo rapporto, in questa relazione temporale e spaziale. Ne viene che vero sarà solo quell’effetto che ha avuto quella precisa causa; vera è l’adaequatio mens et stimulus, la corrispondenza dell’effetto neuronico a quella causa sensoria, alla sua precisa causa. Vista quindi la natura intimamente psico-fisica dell’uomo, non sembrerebbe peraltro corretto parlare di effetto mentale (coscienza del dolore) “distante” dalla causa fisica (dolore fisico), in quanto ogni minima parte del corpo umano è innervato. Eppure una distanza fisico-corporea ad esempio tra il ginocchio e il cervello di fatto esiste, perché è solo qui, nella mens (e non nel sensus) che, sebbene dopo un tempo minimo, cioè al di sotto della soglia di percezione, si prende coscienza del dolore fisico (sensus doloris). Tuttavia è proprio su “esperienze” simili, su “esperienze di soglia” come il sensus doloris che si forma quel sensus communis, cioè il modo di pensare e di conoscere comune, il sentimento naturale.
La patologia dell’Alzheimer è una distorsione del funzionamento di queste strutture del pensiero (tempo, spazio, realtà del mondo); è una particolare forma incurabile di de-menza (mens, mente): una malattia che si presenta propriamente con disturbi della memoria (“tenere a mente”) e di conseguenza di orientamento nel tempo, nello spazio, nel rapporto con la realtà e con gli altri. È una alterazione non solo del Sein, dell’essere, ma anche del Mit-sein, del con-essere, per usare la terminologia heideggeriana fatta propria anche dall’antropologia esistenziale di Ludwig Binswanger.
Una delle principali cause di una tale malattia, secondo gli studiosi, risiede nella placche di una proteina (la beta amiloide) che si formano tra le sinapsi e che bloccano in tal modo il passaggio del segnale nervoso tra una cellula e l’altra. Ancorché dunque a livello cerebrale, la distanza tra B e A, tra causa ed effetto, tra un prima e un dopo, viene in tal modo di fatto annullata e con essa anche il senso della temporalità, della durata e dell’attesa, sicché il paziente sarà costretto a vivere nel presente tutto il passato e forse anche tutto il futuro. Si prefigura così un’esistenza isolata, un isolamento, a causa del quale difficile resta la relazione e la comunicazione con gli altri e con il mondo. Con questi pazienti vi potrà essere soltanto una comunicazione empatica ed emotiva, ma non logica e razionale. Un tale rapporto dovrà pertanto avere come unico fine il riconoscimento dell’esistenza della persona dell’ammalato. «L’esistenza di una persona – scrive infatti l’autrice – sembra essere legittimata solo se l’altro, l’alterità, la riconosce» (p. 120). E, almeno sotto questo aspetto, anche il racconto, la testimonianza di un sopravvissuto alla Vernichtung può essere legittimata solo se chi lo ascolta lo riconosce e vi crede.
2. A causa di questo sfasamento psico-fisiologico, nei malati di Alzheimer accade che il passato venga rivissuto nel presente come se fosse presente. Per essi il passato è il presente e il presente è il passato. A motivo di ciò si verifica in essi uno sdoppiamento dell’io, in quanto pur mantenendo l’io del presente, nel loro dire rievocano e rivivono anche quello del passato, del quale però l’io del presente resta prigioniero. L’io del presente rimane prigioniero dell’io passato. L’io maturo viene piegato dalle istanze dell’io giovanile.
A differenza dello sdoppiamento o della moltiplicazione degli io e quindi delle diverse identità di cui parla tra l’altro anche Proust nella Recherche, qui il soggetto paziente non può più tornare alla coscienza del presente, non può più fare ritorno nella casa del presente, ma resta imprigionato nella casa dell’io del passato. Da qui nasce il senso del suo smarrimento, della sua perdizione. Il suo malessere, inoltre, aumenta ancora di più perché il suo io-presente non riesce a realizzare nel presente quello che desidera il suo io-passato, essendo irrimediabilmente radicato nel suo passato. Egli vive il passato come fosse il presente e non si rende più conto della distanza temporale che esiste tra il passato e il presente. Fonde e confonde passato e presente. Marcel, certo, si mette alla ricerca del tempo perduto, ma poi, alla fine, rientra a casa. A causa di quella proteina, invece, al malato di Alzheimer, pur continuando a vivere nel presente, risulta impossibile riprendere i contatti con il mondo del presente. Egli risiede bensì fisicamente nell’hic, nel qui, ma non vive psichicamente nel nunc, nell’ora, perché il suo ora che vive nel presente appartiene irrimediabilmente al suo passato. O meglio: il malato vive temporalmente un suo ora-presente, nel quale però rivive de-menzialmente il suo ora-passato. Non si tratta pertanto di “nostalgia”, di doloroso desiderio di tornare al proprio passato, alla propria casa d’origine, ma di “topocronopatia”, di distorsione spazio-temporale e quindi anche di disagio esistenziale, quasi mai vissuto consapevolmente.
Oltre che dal modo in cui il passato viene vissuto da Marcel Proust, il rapporto di un malato di Alzheimer con il passato è anche diverso da quello che viene rivissuto da uno scampato alla Shoah. Il disagio vissuto dal malato di Alzheimer nasce dal non poter (se non demenzialmente) compiere nel presente ciò che avrebbe voluto fare in passato; il disagio vissuto da uno sopravvissuto ai Lager nazisti sorge invece dal non voler fare, dal non voler rivivere nel presente il trauma che ha subito in passato. Entrambi sono bensì intrappolati nel proprio passato e assoggettati a una coazione a ripeterlo, ma mentre il malato vorrebbe riviverlo, il sopravvissuto teme di doverlo rivivere. Come un vero e proprio martire, quest’ultimo è per di più lacerato dalla drammatica contraddizione tra il dover ricordare e il voler dimenticare, tra il dover-voler testimoniare e il non poter dimenticare pur volendo dimenticare. Per entrambi è come essere sempre “là”, in quel passato, in quel luogo della memoria, ma mentre in qualche misura il malato è contento di ritornarvi, il superstite, a causa della situazione traumatica subita, entra in angoscia nel momento stesso in cui qualcosa lo rievoca. Non solo: mentre per l’ammalato la memoria e il cosciente recupero della distanziazione e della differenziazione tra presente e passato rappresenta un’ancora di salvezza, perché gli consentirebbero di non venire dimenticato da sé e dagli altri, nel caso dei sopravvissuti è proprio il contrario, giacché la memoria del passato è sempre motivo di perdizione e di dolore. Tutti noi, poi, viviamo nel presente, ma siamo consapevoli della distanza temporale con il passato. Anche il malato di Alzheimer vive nel presente, ma diviene sempre meno consapevole di quella distanza. Insomma, in tutti e tre il passato naturalmente e per qualche motivo tende a ritornare, ma mentre la persona sana riesce a tenerlo in qualche modo razionalmente a distanza (nel senso che può anche rimuoverlo), il malato di Alzheimer, nel quale questa distanza viene meno, non potendolo quindi più rimuovere, lo accoglie inconsapevolmente, invece il sopravvissuto, dissolvendosi anche in lui quella distanza temporale e non potendo quindi nemmeno lui rimuovere quel passato, lo rivive drammaticamente, perché il suo contenuto è doloroso e lacerante.
3. Inoltre, se da un lato alla memoria è necessaria «la distanza temporale e l’equilibrio tra ciò che è ricordato e ciò che viene dimenticato» (p. 105), vale a dire l’equilibrio creato dalla selezione operata dalla memoria sull’intero materiale che essa continuamente immagazzina, all’oblio, dall’altro, è invece essenziale lo squilibrio tra quanto viene ricordato e quanto viene obliato. Perché la parte obliata della nostra vita è incomparabilmente maggiore di quella ricordata. E, per fortuna, di questo nostro singolare modo di essere umani, direbbe Nietzsche, siamo consapevoli solo rare volte, ma quando si verifica ci è davvero spaventoso, perché la memoria della nostra esistenza si riduce veramente a ben poca cosa, a pochissimi frammenti sfocati. Per nostra fortuna, infatti, non siamo come Ireneo Funes, perché possiamo ricordare solo qualche brandello distorto e fugace della nostra breve o lunga esistenza. L’uomo infatti può conoscere se stesso solo dalla minima parte, da quei pochi residui che permangono dei suoi ricordi, in virtù di quella selezione. Senza una tale selezione, e quindi senza il necessario oblio, non ci può pertanto essere conoscenza di sé. Ecco perché i vecchi saggi sentenziavano che “è difficile conoscere se stessi”.
Di noi stessi conosciamo solo una minima parte: quella che, diceva Proust, viene salvata dalla memoria volontaria. In continuità con la psicanalisi freudiana, lo scrittore francese aveva cercato di aumentare la conoscenza dell’uomo provando ad indagare letterariamente anche tutto quel temps perdu, tutti quei mille éléments de tendresse a lui stesso ignoti, insomma tutta quella parte maggioritaria di elementi che la mente vigile ha scartato e che la memoria involontaria ha conservato nel deposito senza fondo dell’inconscio. Di noi stessi, quindi, conosciamo soltanto una minima parte, e ciò nello stesso senso in cui sappiamo solo una esigua parte sia delle potenzialità del nostro cervello sia dell’intero cosmo. D’altra parte è altrettanto vero che sia l’abuso della memoria sia l’abuso dell’oblio, vale a dire sia l’avvicinamento continuo e l’allontanamento dall’evento del passato, inconsapevolmente o meno, producono la dissoluzione e la vanificazione del ricordo.
Ma è la selettività operata dalla memoria a delineare la personalità (p. 113) o è invece la personalità, la particolare sensibilità delle persone, ad attivare la selezione nella memoria? Giacché si può ipotizzare che sia proprio l’inconscio dell’individuo a stimolare la selettività della memoria. Si tratta forse di una scelta inconscia che determina una selezione inconscia nella memoria. Le parti da ricordare e quelle da eliminare vengono decise a livello inconscio. Nulla di volontario, in ogni caso. Sicché, se le cause della rievocazione dei ricordi possono essere conosciute, certamente quelle che determinano la selezione mnemonica restano del tutto inconsce e quindi ignote.
Pertanto, l’aver indugiato così a lungo sulla natura fisica e filosofica del tempo, specie nei capitoli centrali del saggio, non è stato affatto vano, perché è servito a ribadire e a farci capire meglio la relazione filosoficamente ed esistenzialmente assai rilevante e significativa tra il tempo e il modo in cui esso viene percepito non solo dai malati di Alzheimer sia, ma anche, proprio in virtù di questa malattia, dall’uomo in generale.
19 settembre 2019
Visite: 109


 In qualità di insegnante di Storia e Filosofia, ha lasciato un’impronta duratura nel mondo della scuola.
In qualità di insegnante di Storia e Filosofia, ha lasciato un’impronta duratura nel mondo della scuola.