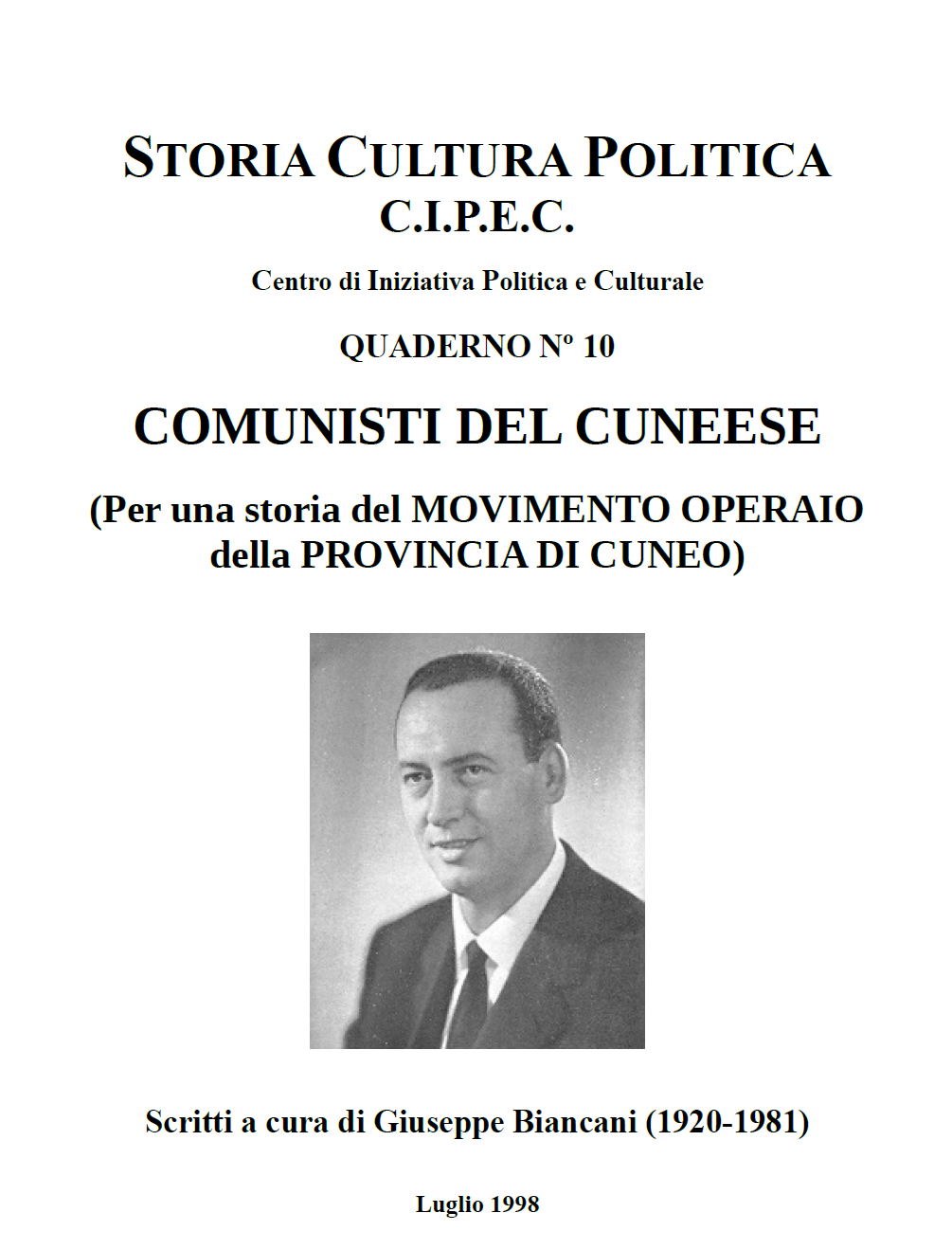Indice generale
INTRODUZIONE p. 5
ESSERE COMUNISTI NEL CUNEESE p. 10
LA GUERRA p. 10
IL FASCISMO p. 13
IL CARCERE p. 18
IL CONFINO E LO STUDIO p. 22
IL LAVORO p. 27
L’EMIGRAZIONE p. 34
LA GUERRA PARTIGIANA p. 38
IL DOPOGUERRA p. 43
ELENCO DEGLI ARTICOLI PUBBLICATI SULLA “VOCE” p. 46
GHINAMO detto “SPARTACO” p. 50
BOVES: 6 anni di vita del CIRCOLO BARALE p. 52
BOVES: il Circolo BARALE. Attività del circolo p. 54
C.I.P.E.C. Attività p. 56
Quaderni C.I.P.E.C. p. 58
(La sintesi antologica degli scritti sulla “Voce” è stata curata da Luigi Bertone.)
Introduzione
Negli anni fra il 1969 e il 1973, a cura di Giuseppe Biancani, fu pubblicata sul periodico della Federazione di Cuneo del PCI “LA VOCE” una serie di articoli su militanti comunisti del Cuneese della prima generazione del partito. Alcuni ebbero taglio autobiografico, richiamando moduli della memorialistica minore; altri sembrano rispondere a un progetto di storia locale del partito articolato su un intreccio di biografie.
La cadenza ravvicinata con cui uscirono testimonia dell’impegno ostinato con cui il curatore perseguì un disegno che trovò nel giornale il suo spazio e i suoi limiti. All’origine c’era la preoccupata coscienza, chiara a Biancani, e non solo a lui, ma forse non altrettanto diffusa e condivisa dentro e fuori il suo partito, della mancanza di una storia d’ambito provinciale del Partito Comunista e dell’antifascismo comunista.
Nè dovette essergli estranea la consapevolezza, in quegli anni di trasformazione della società e di rilettura critica dello stesso patrimonio storico e ideale del Partito Comunista, della possibilità di un dissolvimento della sua identità storica. La rarefazione della memoria poteva diventare un dato patologico, magari accelerato proprio da quei fattori che apparentemente avrebbero dovuto determinarne il consolidamento o l’arroccamento: l’asprezza dello scontro politico e sociale, la disparità delle forze in campo, la cortina di isolamento stesa dalle forze politicamente egemoni nella provincia attorno a quello che si voleva fosse un “corpo estraneo” alla società del Cuneese.
Di più, Biancani intravedeva forse i rischi che potevano derivare anche sul piano della morale civile, della tensione ideale, da processi affrettati di revisione storica e politica che si risolvessero in una mera operazione di rimozione culturale e nel semplice – si fa per dire – ricambio di quadro politico. Rischi percepiti come ben presenti in un lungo momento storico che aveva visto e vedeva, in una sequenza impressionante di eventi: il faticoso e contraddittorio avvio della destalinizzazione; l’Ungheria e il “caso Giolitti”; le lotte di liberazione nazionale in tre continenti; il “centro-sinistra”; il processo innescato dal Concilio Vaticano II; l’immane sconvolgimento della “rivoluzione culturale” cinese; il Maggio francese; la rivolta giovanile; la primavera di Praga; l’avvio dell’autunno caldo e la ripresa delle lotte operaie.
Considerata l’economia delle risorse disponibili, umane e culturali, tutte da investire nella battaglia politica, era persino comprensibile che si fosse atteso tanto, da parte e all’interno del PCI cuneese, per ripensare la propria storia. La necessità di provare, di cominciare a “fare storia”, a guardare dietro e dentro di sè, sembrò così derivare ancora una volta da una esigenza politica: affermare, di quel “corpo estraneo”, il radicamento nella storia della provincia; rivendicare il magistero morale e la lezione civile data dai suoi uomini prima e durante la dittatura e nella guerra di liberazione; riproporre, di quelle figure, l’etica austera. Tentare anche, attraverso i tanti percorsi individuali, di delineare il disegno di una storia collettiva.
Quelli tra il 1969 e il 1973 furono anche gli anni della rivolta studentesca e giovanile, segnati dalla nascita di movimenti in polemica più o meno aspra con il PCI. Può sembrare strano, in quel momento segnato da inedite e crescenti contrapposizioni, l’essersi dedicato Biancani a ricostruire biografie di vecchi comunisti: ma il ridar voce alle utopie sopravvissute alle carceri e all’esilio, il rivendicare con orgoglio matrici e istanze rivoluzionarie di un partito accusato di revisionismo, immobilismo e quant’altro, quando non di complicità e contiguità con il Potere, era anche (o aspirava ad essere) un appello rivolto a quei giovani. Intento onesto, ma ingenuo: quei giovani, nei confronti del PCI e anche della sua storia, si collocavano in posizioni di critica legittima, ma assoluta, spesso tradotta in termini di virulento settarismo. Anche l’antifascismo diventava terreno di scontro, fra una “pratica militante” e un simulacro istituzionale; e l’incomprensione, da parte del PCI, di molto di quel che avveniva tra quei giovani era ripagata ad usura da una chiassosa ostilità. Era del resto del personaggio Biancani un atteggiamento paternamente e pazientemente pedagogico; nè aveva mai nascosto la sua simpatia verso quei giovani che vivevano il loro “sogno di una cosa”. In fin dei conti, erano dei figli, cresciuti proprio all’ombra di quella cortina di isolamento e opacità calata attorno al “corpo estraneo”.
Ci si può chiedere perché, se c’era un progetto, o l’ambizione, di arrivare a una storia locale del PCI, si sia scelta la soluzione meno redditizia di scrivere articoli su un periodico di partito invece di tentare una pubblicazione autonoma, precludendosi così un più vasto pubblico. Come sempre le risposte sono diverse: e alcune prescindono da ovvie e pur presenti motivazioni di costi e problemi editoriali. Una è che senz’altro Biancani aveva in mente la “VOCE” degli anni Cinquanta, e la direzione di Velso Mucci, che aveva saputo dare al giornale un respiro e una personalità mai più eguagliati. Attraverso quella che per alcuni anni costituì una rubrica fissa, c’era l’idea di mantenere aperto uno spazio accessibile a contributi di varia provenienza, e di alleggerire anche il periodico di una certa pesantezza caratteristica di quel periodo.
Un’altra risposta era che Biancani all’epoca aveva cercato, fra giovani e meno giovani intellettuali, dei professionisti, o almeno degli “addetti ai lavori”: raramente gli riuscì di trovarne di disponibili (1).
Forse quella difficoltà a trovare più preparati e validi collaboratori era un segno dei tempi; forse quelle remote vicende di “piccoli maestri” erano viste come marginali, in momenti in cui si sprecavano le analisi a tutto campo, talvolta anche di grana grossa. La conclusione fu che Biancani perseguì il suo disegno da solo o quasi, con ostinazione.
Non essendo uno storico, nè un intellettuale, si inventò come ricercatore autodidatta. Cercò e intervistò protagonisti e testimoni. Ne forzò la ritrosia e la modestia pubblicandone le memorie a loro nome, non figurando neppure come curatore: a metà fra una civetteria sui generis e la soddisfazione di riportare su una ribalta, per quanto modesta, quei nomi che stavano per esser dimenticati. Qualche volta senza dubbio cedette, nella elaborazione del materiale, a toni e modi didascalici, e spesso all’orgoglio di partito. Ma là dove risuonano accenti eccessivamente enfatici si può leggere il grandissimo rispetto per gli uomini della generazione che aveva preceduto la sua, che avevano tenuto duro per più di vent’anni; che avevano sopportato la sconfitta e l’isolamento e che vivevano una vecchiaia appartata, paghi di una fedeltà al loro ideale semplice e incorrotta.
Perché Biancani si riservò questo tipo di impegno, e quasi ci si isolò? È come se, dopo quasi due legislature da parlamentare, non avesse ritrovato un ruolo nell’organico della Federazione. Per la verità non fu così: è di quegli anni il fecondo incontro, che Biancani perseguì con convinzione, entusiasmo, e altrettanta ostinazione, con i settori del mondo cattolico cresciuti nello spirito del Vaticano II. È anche di quegli anni l’impegno per la “distensione”, come si diceva allora, in campo internazionale, magari passando attraverso un antifascismo istituzionale ma che serviva a sfumare sospetti, diffidenze e pregiudizi radicati e spesso motivati.
Forse si può dire che, a soli cinquant’anni, Biancani si fosse ritagliato – o gli fosse stato cucito addosso – un ruolo di “saggio”, vuoi per una sua avversione al settarismo, costituzionale o maturata che fosse nell’esperienza, vuoi per una sua curiosità per le diversità culturali che lo inducevano ad un approccio rispettoso verso “gli altri”. Ciò nonostante, è mia impressione che anche questo ruolo non sia stato da lui vissuto in modo indolore e meno che mai compiaciuto, e che sia stato un aspetto di una certa sua solitudine: anche se lo stesso Biancani non l’avrebbe mai ammesso.
A più di vent’anni dalla pubblicazione di quegli articoli, non si può dire se l’aspirazione di Biancani, se non a fare storia, almeno a stimolare l’interesse di migliori e più dotati ricercatori, abbia mancato il suo scopo. Una storia del PCI e dell’antifascismo comunista del Cuneese è ancora da scrivere; ma è altrettanto vero che con l’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo, che proprio in quegli anni era stato fondato e andava sviluppando e precisando una fisionomia unica di organismo produttore e propulsore di cultura, è cresciuta una generazione di giovani e validi studiosi e hanno visto la luce saggi, ricerche e tesi di laurea che hanno fatto e fanno giustizia di un’immagine della provincia di Cuneo come una zona culturalmente e politicamente opaca.
Tutti questi spezzoni di biografie, o di autobiografie, sono attraversati da una trama costante di temi generali e di eventi individuali che confluiscono a formare il patrimonio esistenziale di una generazione. Lì si consolidano, in una sorta di substrato culturale che è durato ben oltre lo spazio di quella generazione, amplificandosi e diventando la carta di identità di un intero movimento politico, quella che, o con orgoglio o con spirito polemico, si è voluta definire una “diversità”.
È forse proprio nella condivisione di quelle costanti esistenziali che si è tentati di parlare di una storia collettiva, che è qualcosa di differente – mi pare – dalla storia di un partito, o di un movimento politico. Forse assomiglia di più alla storia di una banda partigiana, per l’importanza che vi ha l’impronta individuale.
Tutti condividono un valore appartenente alla tradizione e alla storia del movimento operaio come l’orgoglio del proprio lavoro, per duro che possa essere, che solo dà dignità all’umile di fronte allo strapotere del privilegio, e la cui difesa è sempre vissuta in modo fortemente antagonistico: nè potrebbe essere diversamente, dati i tempi. Anche quando in molti sono costretti a cambiare continuamente lavoro a causa dei licenziamenti e delle persecuzioni poliziesche, tutti sopportano con grande dignità una condizione che spesso è poco più che vivere di espedienti. Espulsi dalla fabbrica, privati degli strumenti dell’arte e della bottega, cacciati dalle professioni, per così dire si mettono in proprio, attraversando da un mestiere all’altro la struttura economica di una società ancora fitta come un alveare di piccole e piccolissime imprese artigianali ed esercizi commerciali, spesso al limite della sopravvivenza economica.
In stretta analogia alla funzione di promozione sociale ed esistenziale costituita dal lavoro troviamo lo studio, che, già inaccessibile a molti a cagione della loro povertà, si incontra e viene praticato come una disciplina nelle condizioni più dure: nell’emigrazione, al confino o in carcere, con maestri impareggiabili.
Paradossalmente pare persino di intravedere, in certi ricordi di emigrati, di ex confinati o ex carcerati che parteciparono allo studio e alla formazione politica, una condizione più fortunata di quella di quanti, privi di ogni contatto, vissero nell’isolamento e sentendosi il vuoto intorno; oppure della vita delle mogli e dei figli rimasti soli a casa, con l’unico conforto di una corrispondenza fitta e fervida di consigli ed istruzioni, che talvolta – come nel caso delle lettere di Giovanni Barale ai figli – evocano una sorta di pedagogia della resistenza, che nulla concede alla disperazione e alla sconfitta.
Di tutt’altro tenore, ma ispirate dalla stessa concezione della cultura come veicolo di dignità e riscatto, alcune delle pagine scritte dall’avvocato Carlo Bava, spirito giacobino, anticlericale e antimilitarista, perennemente irridente a quella incolta minuta borghesia che dall’orbace traeva di che indegnamente sopravvivere, e al suo miserabile conformismo.
Emerge in alcune memorie il ricordo terribile della prima guerra mondiale, la matrice sciagurata delle dittature europee del XX secolo. Nel rifiuto assoluto delle ragioni di quella guerra ritroviamo l’antimilitarismo storico del movimento operaio, maturato al fronte e negli ospedali militari come nelle retrovie alla fame, e nelle famiglie private dei padri, dei mariti, dei fratelli, dei figli. L’alterità culturale di quella generazione di militanti vi crebbe e si rinforzò come antagonismo irriducibile, anche nutrito dalla rivolta morale contro il patriottismo ufficiale, correttamente percepito e interpretato come copertura ideologica e propagandistica della “inutile strage” e dei lauti profitti che essa assicurava. In questa prospettiva, il disfattismo dei poveri, dei soldati tolti agli ospedali e spediti al fronte, assume una valenza rivoluzionaria.
Di ben altra natura il patriottismo professato e praticato in prima persona durante la guerra di liberazione, quando le istanze unitarie e di riscatto nazionale del partigianato e dei C.L.N. sembrano finalmente incarnare una antica utopia di rigenerazione sociale.
L’inevitabilità di una visione antagonistica e senza mediazioni dello scontro tra le classi, l’adesione entusiastica e la interminata fedeltà a un ideale perfino messianico, di rigenerazione millenaristica, trovano anche le loro radici nella generalizzata, aspra povertà dei primi anni del secolo rievocata da molti testimoni. La povertà, e la fatica di un lavoro senza riposo e senza regole, se non quelle imposte da una ragione di scambio disumana, sono note frequenti, se non costanti, della memoria; e, quel che è più terribile, quelle che accompagnano quasi sempre i ricordi d’infanzia e dell’adolescenza. Il tempo di crescere arrivava troppo presto: altrettanto presto molti si votavano a quell’ideale di riscossa e di riscatto predicato come una fede da personaggi percepiti più come apostoli che come eroi popolari.
Negli articoli dedicati ad alcuni personaggi si intravedeva proprio il tentativo di descrivere la genesi di un capopopolo, quelle rare figure di umili leader popolari, il cui carisma è fatto di onestà cristallina, quieto e tenace coraggio, intelligenza lungimirante, abnegazione e spirito di sacrificio. Si tratta di figure capaci di catalizzare spontaneamente la fiducia unanime, spesso anche da parte di avversari, grazie a qualità umane e morali indiscusse.
Mi pare singolare e degna di attenzione, a questo proposito, la quasi totale assenza in queste memorie – con l’eccezione forse dell’avvocato Bava – di un tema polemico come l’anticlericalismo. A mio parere non si è in presenza di un flagrante e generalizzato opportunismo, magari praticato a posteriori; nè credo si possa pensare a una discreta censura esercitata dal curatore. Semmai è probabile che si sia trattato di una cosciente auto censura, guidata proprio da quello spirito di abnegazione che impone di considerare fatti e esperienze anche dolorose alla luce di una valutazione che travalica la dimensione personale e la sovrasta, quale quella del politicamente giusto e opportuno. Forse è un peccato per il ricercatore: ma molto probabilmente parecchi, pur nell’occasione di denunciare prepotenze subite, hanno messo la sordina alla tentazione di richiamare in vita contrapposizioni frontali dolorose e rovinose.
È – paradossalmente – proprio dal loro essere stati uomini profondamente di parte che credo possa esser venuta quella che definirei una coscienza superiore, pronta alla negazione di sé in vista di un’idea di bene collettivo: magari aurorale, messianica e poco scientifica, magari anche poco politica, ma onesta e luminosa.
(1) Con qualche eccezione: l’avvocato Carlo Bava e il partigiano Ezio Aceto; la giovane insegnante Maria Vittoria Migliano Montagnana, (tesi di laurea: “Aspetti della narrativa dei fuorusciti durante il ventennio: i tentativi di narrativa popolare antifascista di Teresa Noce e Giovanni Germanetto“, rel. E. Bonora, Facoltà Magistero Torino, c/o Centro Studi Piero Gobetti). Più avanti le cose cambiarono: il compianto Arturo Oreggia collaborò alla autobiografia di Adele Faraggiana (Edizioni “LA VOCE” 1977); Mario Giovana curò una biografia di Giorgio Giraudo (“Vita di comunista”, su “Notiziario dell’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo, n. 27 del giugno 1985) e pubblicò un lavoro che era stato molto a cuore a Biancani, la storia del fossanese Luigi De Marchi (“Il caso De Marchi”, Milano, F. Angeli, 1993); chi scrive diede una mano per l’autobiografia di “Pietro” Comollo (“Il Commissario Pietro”, edizione ANPI Piemonte, Torino, 1979) e portò a termine una ricerca sulle S.A.P. cuneesi, per la quale Biancani, con l’aiuto degli ex Sappisti, aveva raccolto la maggior parte del materiale (“Le S.A.P. a Cuneo nella lotta di liberazione”, in Notiziario dell’I.S.R.C., n. 27 giugno 1985).
Claudio Biancani